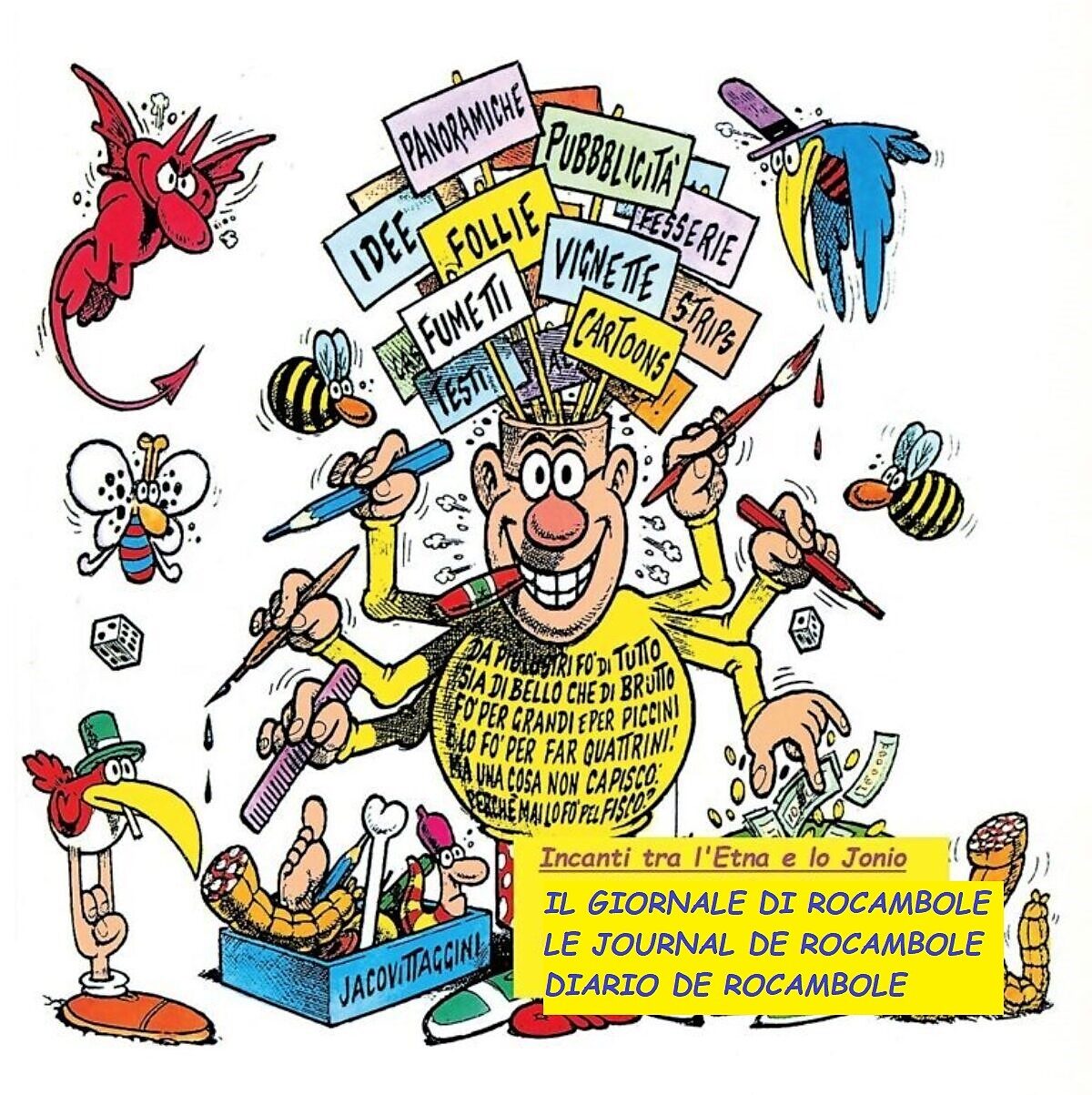Il Sessantotto di Omero
di Luisa Fiorello
Posò il telefono e in quel momento stesso decise che doveva ucciderlo.
Non poteva continuare così.
Le aveva telefonato dalla casa della sua ultima amante, descrivendone le qualità fisiche e paragonandole con scherno alle sue.
Aveva ancora le chiavi dell’appartamento di lui; lei aveva dimenticato di restituirgliele e lui di chiedergliele.
Decise quindi di recarsi da lui, nascondersi nel ripostiglio ed aspettare che rincasasse e si addormentasse.
Si vestì in fretta; la bambina dormiva. Poteva lasciarla sola, una bambina di sette anni? Decise di sì, non si svegliava mai la notte e lei sarebbe tornata entro un paio d’ore.
Uscì di casa e si avviò verso la stazione della metropolitana. Scese alla stazione di Saint-Germain dès Près e si avviò verso rue Bonaparte.
Gli alberi del boulevard sbocciavano in tutta la loro bellezza e lei ripensò alle passeggiate con lui per i lungosenna, mano nella mano, nei primi tempi del suo arrivo a Parigi.
Per lui aveva lasciato il marito- d’altronde erano in crisi da parecchio tempo- e aveva affrontato l’avventura di trasferirsi a Parigi, portando con sè la bambina e iniziando una nuova vita con quell’uomo così bello, così colto, così raffinato, e così giovane.
La differenza di età- lui venticinque, lei trentacinque- non l’aveva mai spaventata.
Piccola, esile, due grandi occhi scuri in un viso dai bei lineamenti, sembrava una ragazzina. Talmente esile che spesso la paragonavano a Twiggy, la famosa modella inglese.
Era una sognatrice con poco senso pratico, abituata ad essere sempre considerata un po’ infantile, giustificata con indulgenza da tutti per i suoi comportamenti immaturi, ma che erano tutto sommato egoistici.
Era concentrata su stessa, logorata dal desiderio di dare alla sua vita una dimensione eccezionale, fuori dagli schemi e dai comportamenti usuali.
Con lui si erano conosciuti ad una conferenza su Flaubert: lui era lettore di Francese all’Università e lei un’attrice che di tanto in tanto era invitata a leggere poesie e brani di prosa in conferenze e convegni.
Lui si era complimentato per la sua voce e la sua dizione e lei era rimasta incantata dall’accento parigino del suo italiano, molto corretto, quasi letterario.
La sua partecipazione come attrice in una piccola compagnia d’avanguardia della sua città l’aveva messa in contatto con un mondo fatto di personaggi eccezionali, di donne dai grandi e tragici destini: sognava di interpretare Antigone nei teatri greci o il ruolo di Nora in “Casa di bambola” nei grandi teatri delle capitali.
Quel mondo fittizio l’aveva resa insofferente della vita quotidiana familiare che le toccava vivere; il marito era un impiegato alle Poste: un brav’uomo simpatico, allegro, divertente che l’adorava, ma lontanissimo dai suoi sogni e dalle sue aspettative.
La nascita della bambina non aveva cambiato granchè; certo le voleva bene, ma preferiva che altri l’accudissero risparmiandole fastidiosi pannolini e biberon.
D’altronde il marito stravedeva per la piccola e se ne occupava a tempo pieno.
Quando conobbe il giovane francese era già ad un punto di rottura con la sua vita di sempre; era pronta per qualcosa di diverso, di nuovo, di eccitante.
Lui le parlava di Flaubert, le svelava che esistevano due versioni dell’Education sentimental e lei si sentiva arricchita culturalmente standogli vicino.
Iniziarono una relazione e quando il giovane ebbe concluso il suo contratto con l’Università e deciso di rientrare a Parigi, proponendole di seguirlo, le sembrò di toccare il cielo con un dito. Ecco la sua occasione, ecco la svolta definitiva della sua vita: Parigi, la grande capitale, crogiolo di culture, un mondo nuovo , diverso dalla soffocante città di provincia nella quale era vissuta fino a quel momento.
Si sentiva esattamente come il grande personaggio creato da Flaubert e come lui diceva di sé sorridendo : “ Madame Bovary, c’est moi!”
Stranamente decise di portare con sé la bambina; era già grandicella, abbastanza autonoma e uno strano sentimento mai avvertito prima- un inizio di amore materno?- le faceva capire che la bambina le sarebbe mancata. Quindi, con un ulteriore atto d’egoismo, decise di portarla con sé, riuscendo a convincere il paziente marito – dal quale si era di fatto separata da qualche tempo- che sarebbe stata via solo per qualche mese.
A volte, provava anche un po’ di rimorso pensando al marito: era sempre stato innamoratissimo di lei, l’aveva accontentata in tutto, cieco ai suoi difetti e alle sue smanie di una vita diversa. Poi pensava ad Emmma Bovary e si diceva sorridendo: “Ecco mio marito è proprio come il marito di Emma! Tanto buono, ma tanto noioso!”
All’inizio la sua vita a Parigi era stata stupenda: il giovane era molto affettuoso con lei e la bambina; le aveva accolte nel suo appartamento, piccolo ma al centro di Parigi, in rue Bonaparte; la portava spesso a teatro, ai concerti, le faceva conoscere persone interessanti: in quei casi la bambina restava a casa con una baby sitter.
Aveva iniziato a studiare il francese, sempre accarezzando il sogno di poter recitare a Parigi in una grande compagnia, lei che era stata tante volte applaudita e apprezzata nella sua città.
Passava la giornata studiando, leggendo, riordinando la casa- lei che non aveva mai lavato un piatto- e cucinando la sera per lui. Anche questa era una novità: lei mangiava pochissimo, a pranzo la bambina mangiava a scuola , lui restava all’università e rientrava la sera. E lei che aveva sempre odiato i fornelli, sperimentava ora nuove ricette, cercando di preparare invitanti cenette.
Ma come quasi sempre, in questi casi, il sogno cominciò a frantumarsi giorno per giorno: lo sentiva un po’ più distaccato, meno appassionato, fino al giorno in cui le propose di trasferirsi- lei e la bambina- in un appartamento nella banlieu di Parigi, perchè- le spiegò- aveva bisogno di maggiore spazio e libertà per alcuni contatti con gente del mondo universitario che poteva essergli utile per una definitiva sistemazione.
La cosa la sorprese dolorosamente: non sarebbe stato lo stesso vivere da sola, senza la sua presenza quotidiana, vedendolo come un ospite in visita.
E infatti dal quel giorno lo vide sempre più raramente; veniva a trovarla una o due volte la settimana, le dava i soldi contati per la spesa- con evidente, crescente fastidio- e lei sentiva che lo stava perdendo. Capiva anche che aveva altre donne- sicuramente giovani come lui- e quando andava a trovarla gli faceva scenate di gelosia che certamente non miglioravano la situazione e delle quali poi gli chiedeva perdono in lacrime con reiterate richieste di pace.
Fino a quel giorno in cui le aveva telefonato dicendole che in quel momento si trovava con una ragazza bellissima, che aveva dei seni stupendi- lei non se li sognava nemmeno -; aveva capito allora definitivamente che lui non la voleva più e che , vigliaccamente, faceva di tutto per umiliarla, disgustarla e staccarla da sé.
Fu presa da un furore cieco e decise di ucciderlo: non meritava altro.
Come l’avrebbe fatto? Non lo sapeva bene, l’avrebbe deciso sul momento.
Era già quasi sera e il cielo di Parigi di un azzurro intenso cominciava ad incupirsi trasformandosi nel nero mantello della notte.
Si fermò sul Pont Neuf e si affacciò a guardare le acque scure della Senna sulla quale scivolavano i bateaux-mouches carichi di turisti che si affannavano a fotografare quanto più potevano, dimenticando, nel farlo, di gustare con calma le bellezze che li circondavano.
Quanta gente si era buttata giù da quel ponte! Quanta disperazione aveva riempito il cuore di quei poveri disgraziati per indurli a commettere un gesto così disperato. Lei avrebbe potuto farlo? No, non ne aveva il coraggio. L’impatto con l’acqua fredda, il respiro sempre più faticoso, la lotta per emergere dalle onde che ti spingono giù, giù..l’inutile, tardivo pentimento di quel gesto! Rabbrividì al pensiero di tutto questo e si avviò verso la sua destinazione.
Arrivò a casa di lui, aprì la porta ed entrò nel piccolo atrio dal quale si accedeva da un lato al soggiorno e dall’altro alla camera da letto.
L’appartamento era silenzioso: si sentiva solo il ticchettìo dell’orologio a pendolo, che lui aveva ricevuto in eredità dal nonno.
Girò per la casa guardandosi intorno: ogni angolo le riportava alla mente un ricordo particolare, gioioso, felice.
Il piccolo tavolo da pranzo sul quale consumavano la cena e poi giocavano a carte, cercando di far partecipare e divertire la bambina; la grande poltrona soffice , comoda , sulla quale lui si sedeva con lei in braccio, le coccole che preludevano alle loro notti d’amore.. Si sedette su quella poltrona e finalmente pianse; pianse su stessa, sull’ingiustizia della sua vita che le rendeva odio in cambio dell’amore che lei aveva dato. Perchè lei aveva solo amato, non aveva fatto male a nessuno e tanto meno a lui: dunque, perchè le era capitato tutto questo? Perchè proprio a lei? Come tutte le persone egoiste- quando la vita le mette alla prova- si poneva questo interrogativo, “Perchè proprio a me?” Ma perchè no? Se capitasse ad un altro sarebbe meno ingiusto? Questa riflessione fece montare di nuovo in lei la rabbia e la determinazione di ucciderlo. Sarebbe stata finalmente libera, libera dall’ossessione di quell’uomo!
Aprì la porta del piccolo ripostiglio e gli occhi le si posarono su una cassetta di attrezzi aperta per terra: in primo piano vi era posato un grosso martello.
Lo guardò a lungo ipnotizzata: pensieri di violenza, di aggressione, di morte sfilarono nella sua mente. Poi tirò un lungo respiro, socchiuse la porta del ripostiglio, lasciando una fessura aperta, afferrò il martello e stringendolo convulsamente fra le braccia, si sedette per terra e attese.
Mentre aspettava raggomitolata per terra, le sfilarono davanti agli occhi della mente tutti i giorni della sua vita: l’infanzia serena in una famiglia modesta – il padre operaio, la madre casalinga- al limite della sopravvivenza; gli studi in un istituto tecnico- lei che amava l’arte, la poesia, il teatro- con il relativo diploma di ragioniera e nessuna esperienza pratica in quel genere di lavoro; gli impieghi saltuari e sempre frustranti – fatture, conti, datori di lavoro cafoni o prepotenti- e infine, unico momento appagante della sua vita, l’incontro con il giovane regista che l’aveva accolta nella sua compagnia, aveva capito le sue potenzialità artistiche e le aveva offerto la possibilità di recitare e di realizzare almeno in quei momenti sul palcoscenico i suoi sogni.
Così gli anni erano passati e anche il teatro era diventato per lei una routine; le mancavano i grandi teatri, il pubblico delle capitali, gli applausi per le sue interpretazioni da parte di grandi registi e grandi critici.
Per lei fare l’attrice significava soprattutto essere famosa e guadagnare tanti soldi e capiva che questo non le sarebbe più accaduto restando a vivere e a recitare in quella soffocante cittadina di provincia, dove i grandi attori e i grandi registi erano solo di passaggio e non andavano certo a vedere lei in quella piccola compagnia locale.
Il rumore della chiave che girava nella porta interruppe i suoi pensieri. Eccolo, era tornato! Il respiro le si fermò; rimase immobile continuando a stringere il martello fra le braccia. Si sentì il tintinnìo delle chiavi sul ripiano del tavolinetto dell’ingresso, quindi i passi di lui che si dirigevano verso il bagno. Sentì quasi subito scrosciare l’acqua della doccia, poi un ciabattare che dal bagno si dirigeva verso la camera da letto, poi più nulla.
Evidentemente era andato a letto. Il silenzio cadde di nuovo nell’appartamento.
Il cuore le batteva così forte che temette per un momento che il rumore lo svegliasse.
Attese ancora dieci minuti. Era tutta coperta di sudore e tremava come una foglia. Infine si fece forza e uscì dal ripostiglio. Si tolse le scarpe e in punta di piedi si avviò verso la camera da letto. La porta era socchiusa. Rimase ad ascoltare e sentì il respiro pesante dell’uomo che dormiva. Si infilò nella fessura della porta rimasta aperta- era così magra che poteva passare senza farla muovere e cigolare- e si avvicinò al letto.
Eccolo lì: era disteso, supino,con un braccio alzato sopra la testa e appoggiato al cuscino e respirava pesantemente.
Com’era giovane! E bello! I capelli castano chiaro si arricciavano alle tempie circondando un viso dai lineamenti regolari: il suo bel corpo snello si distendeva rilassato nel sonno.
Un peccato doverlo uccidere, ma solo così avrebbe avuto pace.
Per trovare la forza di alzare il braccio e vibrare il colpo, si impose di ricordare le telefonate di scherno che aveva ricevuto da lui negli ultimi tempi, il continuo paragonarla alle sue amanti, il costante desiderio di umiliarla per staccarla da sé .
La rabbia montò di nuovo in lei a quel pensiero. Alzò il braccio e vibrò il colpo, ma il tremito che la scuoteva tutta fece sì che il martello colpisse la fronte del giovane di striscio, ottenendo solo di farlo svegliare.
Aprì gli occhi con un sussulto e per pochi secondi rimase a guardarla intontito con l’inconsapevolezza del sonno appena spezzato, mentre lei, inorridita, lo guardava a bocca aperta, continuando a tremare.
Quando mise a fuoco il suo viso e osservò sbalordito il martello che lei impugnava ancora, balzò dal letto e afferrò con una mano di ferro il polso sottile di lei, stringendolo finchè non lasciò cadere il martello.
Volevi uccidermi? Sei pazza, sei pazza!L’ho sempre saputo che eri pazza!..
Sei tu che l’hai voluto…tu!
Il giovane continuando a stringerle il braccio in una morsa, la trascinò con sé verso il telefono che si trovava sulla scrivania e digitò il numero del pronto intervento della polizia.
Una donna ha cercato di uccidermi. Venite subito. Sono riuscito ad immobilizzarla. Sono al 15 di rue Bonaparte.
La strattonò ancora fino ad una sedia e ve la gettò sopra. Lei si accasciò come un sacco vuoto, continuando a tremare.
Pochi minuti dopo la polizia era arrivata; due agenti alti e robusti guardarono meravigliati la donna esile e pallida accasciata sulla sedia .
Voleva uccidermi: guardate, questo è il martello con cui ha vibrato il colpo sulla mia testa, mentre dormivo. Vedete questo livido sulla tempia?
I poliziotti guardarono il piccolo livido, poi il giovane alto e robusto, quindi la donna fragile e tremante sulla sedia e sorrisero.
Una lite fra innamorati?
Neanche per sogno. E’ una pazza! Dovete rinchiuderla in un manicomio criminale.
Non pensa- disse uno dei poliziotti- che dopo esservi calmati entrambi, guardi la signora come sta tremando, potreste chiarire tutto e far finta che non sia successo niente?
Successo niente? Ha cercato di uccidermi, vi dico! Non avete sentito? Dovete fare il vostro dovere. Arrestarla e rinchiuderla in manicomio. E’ completamente pazza!
La sua dunque è una denuncia formale?
Certo, volete che la metta per iscritto?
Non adesso. Verrà domani mattina a firmare una dichiarazione.
I due poliziotti a malincuore si avvicinarono alla donna e la presero entrambi per un braccio delicatamente, tirandola su con cautela e quasi compassione.
Guardarono di nuovo il giovane:
E’ proprio sicuro?
Sicurissimo!
Andiamo signora, venga.
Lei cominciò a camminare quasi trascinata dai due poliziotti. Ad un tratto un pensiero le balenò in mente.
La bambina- disse- cosa ne sarà della mia bambina?
Una bambina? C’è una bambina in casa?
No, è nel mio appartamento. E’ rimasta sola; devo andare a prenderla.
I poliziotti si fecero subito più severi. C’era un minore di mezzo e per giunta lasciato solo di notte: la faccenda era più grave di quanto non sembrasse a prima vista.
Quanti anni ha la bambina?
Sette anni.
E lei ha lasciato sola di notte una bambina di sette anni. Andiamo. Ci dica dove si trova.
La fecero salire in macchina e si recarono al suo indirizzo. Entrarono in casa ed entrarono con lei nella camera dove dormiva la bambina. Accesero la luce e la piccola si svegliò. Sgranò i grandi occhi grigi, guardando sbalordita i due uomini sconosciuti, poi sfregandosi gli occhi si rivolse alla madre:
Chi sono questi uomini, mammina?
Lei non rispose; solo allora, guardando la figlia, ancora insonnacchiata, si rese conto dell’enormità delle sue azioni. E ora? Cosa ne sarebbe stato di lei? Guardò disperata i poliziotti.
Uno dei due – aveva anche lui una bambina e cominciava a pensare che quella donna fosse davvero pazza- le si rivolse bruscamente:
La bambina non può restare qui da sola né venire con lei. Dov’è il padre?
In Italia.
Non ha un’amica che possa tenerla finchè non arriva il padre?
Lei cercò di pensare a chi poteva rivolgersi. Le sembrava di avere la testa imbottita di bambagia: i pensieri nascevano e svanivano subito dopo.
Cercò di ricordare il nome di qualche amichetta della figlia e si ricordò della piccola Alessandra, compagna di banco della bambina, e della madre di lei, una signora italiana molto gentile che aveva conosciuto quando aveva accompagnato la figlia alla festa di compleanno di Alessandra. Sì, aveva l’indirizzo e il telefono. Poteva chiamarla, ma era tardi: erano le due di notte.
Non importa- dissero i poliziotti- la chiameremo noi e la pregheremo di tenere la bambina fino all’arrivo del padre.
La piccola non diceva niente; era abituata ai mutamenti della sua vita; agli umori di sua madre, raramente allegra, ma più spesso triste, depressa, quasi sempre distratta nei suoi confronti. Non aveva capito perchè aveva dovuto lasciare il padre che le voleva tanto bene e seguire la madre in quella grande città sconosciuta, dove tutti parlavano una lingua che lei non capiva. Poi a poco a poco si era abituata; a scuola- una delle tante scuole italiane all’estero- aveva fatto amicizia con Alessandra ed era andata qualche volta a casa sua e aveva guardato con ammirazione le attenzioni della madre verso la figlia, le coccole, le risate, l’allegria che regnava in quella casa.
Era contenta di andare da Alessandra; da lei si sentiva più al sicuro che con sua madre.
La mamma di Alessandra fu gentilissima; nonostante l’ora, accolse la bambina con un bel sorriso stringendola piano a sé e dicendole: “Vai a dormire nel letto di Alessandra. Tu sai dov’è”. Poi assicurò ai poliziotti che avrebbe avuto cura della piccola fino all’arrivo del padre.
Sistemata la bambina, i poliziotti portarono la donna al commissariato e la tennero per quella notte in una cella.
La mattina seguente telefonarono al marito in Italia, il quale si precipitò subito a Parigi insieme con la sorella di lei.
Quest’ultima- una donna concreta, sposata ad un ingegnere, non era stata mai molto tenera nei confronti della sorella, tanto diversa da lei. Aveva sempre considerato con sprezzante indulgenza la sua attività di attrice , considerandola un hobby e disapprovando il suo modo di vivere.
Questo non le impedì tuttavia di correre in suo aiuto.
Nel frattempo la donna era stata trasferita al manicomio criminale e, poiché era andata in escandescenze quando l’avevano messa in una stretta stanza senza finestre, arredata soltanto con una branda , un comodino e una sedia, le avevano messo la camicia di forza e le avevano somministrato un calmante.
Rimase lì istupidita e immobile chiedendosi come la sua vita fosse giunta a tanto. Cosa aveva fatto di male per meritarsi tutto questo? Certo, aveva cercato di uccidere il suo amante, ma non se lo meritava? Come aveva potuto trattarla in quel modo?
I suoi pensieri erano pieni di compassione per se stessa. Sarebbero riusciti suo marito e sua sorella a tirarla fuori di lì?
Rivide la casa dove era vissuta con il marito, i giorni monotoni ma sereni, le sue battute sempre piuttosto scontate, tipiche di un uomo semplice, senza grandi ambizioni. Forse era quella la vita giusta? Forse doveva accontentarsi di quella serena monotonia, ravvivata di tanto in tanto dalle prove in teatro, dai debutti, dall’ansiosa ricerca sul giornale locale del suo nome nelle recensioni di giornalisti più o meno competenti. E la sua bambina? L’aveva trascurata, non era stata mai particolarmente affettuosa con lei, non aveva badato alle sue esigenze , alle sue piccole necessità, non le era stata mai veramente vicina. Pensò che se fosse riuscita ad andar via da quel posto, si sarebbe sforzata di riprendere quella vita tranquilla, addirittura forse sarebbe tornata con il marito, il quale – lei ne era convinta- non aspettava altro.
Dopo alcune ore, vedendola tranquilla, le tolsero la camicia di forza e le permisero di recarsi nella sala comune dell’ospedale psichiatrico.
Lì l’aspettava una visione orribile. Una ventina di donne stavano sedute attorno a dei tavoli, giocando a carte o chiacchierando e quando si voltarono a guardare la nuova arrivata, lei sentì su di sé occhi ostili, gelidi. Una di loro si alzò e le si avvicino sorridendo, molto vicina al suo viso, poi, prima che lei potesse muoversi, le appioppò uno schiaffo violentissimo in piena faccia; quindi andò di nuovo a sedersi al suo tavolo, mentre le altre ridevano sgangheratamente.
Lei rimase immobile, sconvolta; non le era mai successo di essere colpita: la sensazione che provava era indescrivibile; era un misto di stupore, rabbia, umiliazione, dolore, senso dell’ingiustizia. Perchè? Perchè quella donna l’aveva colpita? Lei non le aveva fatto niente. Scoppiò a piangere correndo fuori dalla stanza e cercando l’infermiera, che nel frattempo era accorsa.
Non voglio stare con le altre,vi prego. Lasciatemi nella mia stanza. Voglio stare da sola.
Pensi di essere in albergo? Di poter fare quello che vuoi? Devi stare alle regole come tutte le altre.
Lei allora cominciò a gridare e a battere i pugni sull’infermiera, pensando che così forse l’avrebbero di nuovo rinchiusa nella sua stanza. Era preferibile la camicia di forza a quella compagnia orribile. E così fu. Le rimisero la camicia di forza e la riportarono nella sua stanza.
Nel frattempo il marito e la sorella erano arrivati e recatisi al commissariato, si erano incontrati con il giovane accusatore che era lì per stendere una formale denuncia.
Gli parlarono a lungo e lo convinsero a ritirarla . Quindi mentre il padre della bambina andava a riprendere la sua piccola dall’amichetta, la sorella si recò al manicomio dove le avevano detto che era stata rinchiusa la sorella.
Lì aspettò circa un’ora, guardando inorridita attorno a sè. Come aveva potuto ridursi così sua sorella? E per un uomo poi! Lei che non aveva molta stima del genere maschile- il marito gliene faceva vedere delle belle, ma lei era quel tipo di donna che, per amore dei figli e della famiglia, cercava di sopportare- non riusciva a concepire questi sentimenti estremi che portano ad azioni incontrollabili, fuori da ogni razionalità.
La sorella era sempre stata strana, piena di idee grandiose, fuori dalla realtà; anche un po’ viziata, bisogna dire, perchè aveva sempre avuto qualcuno che aveva provveduto a lei: prima suo padre, poi il marito- povero ragazzo quante gliene aveva fatte vedere!- poi l’amante francese e adesso lei che aveva dovuto sbattersi a Parigi per toglierla dai pasticci. Sbuffò impaziente guardando l’orologio: quanto doveva aspettare ancora?
Finalmente le permisero di recarsi nella stanza della sorella, alla quale nel frattempo avevano tolto la camicia di forza. La trovò seduta sulla sedia come un mucchietto di stracci . Una grande compassione la invase e lei, che non era stata mai molto espansiva, la prese fra le braccia e la strinse a sé.
Non preoccuparti. E’ tutto finito. Torniamo in Italia.
Lei non disse niente; si lasciò abbracciare restando inerte e passiva. La sorella l’aiutò a vestirsi, a mettere nel borsone le poche cose che aveva portato dall’appartamento quando i poliziotti ve l’avevano accompagnata, e finalmente uscirono. Raggiunsero con un tassì l’aeroporto dove li aspettava il marito con la bambina e tornarono in Italia.
Qui non riuscì a riprendere la vita di prima. Restava ore intere a letto, abulica, alzandosi solo per mangiare qualcosa; continuava a pensare a ciò che le era successo e si diceva “ E’ una storia tragica, la mia. Ecco, si potrebbe scrivere un dramma su questa mia vicenda. E io la reciterei da protagonista.” Ma poi rideva di se stessa e capiva che la storia doveva avere un altro finale se voleva diventare un vero dramma. Cominciò a pensare e a ripensare e finalmente ebbe tutto chiaro.
Si alzò, si lavò, si vestì, mangiò qualcosa, quindi chiamò un taxi e si recò all’aeroporto. Qui prese il primo volo per Roma, quindi un altro per Parigi. Dall’aeroporto si recò con un altro taxi all’Ile de la Cité, nel punto in cui si congiunge con l’Ile Saint-Louis: quello era uno dei posti romantici di Parigi che lei adorava e nel quale si era recata spesso con il giovane amante nei primi tempi del suo arrivo a Parigi. Un piccolo giardino fioriva in quell’angolo e in quel periodo dell’anno era tutto pieno di rose, giacinti e fresie che emanavano un profumo dolcissimo. Era tutto così bello in quell’angolo di Parigi: come avrebbe trovato il coraggio di fare quello che aveva deciso di fare?
Dal quai scese per la scaletta che portava alla banchina sul fiume. Sotto l’arco del ponte c’era un uomo seduto su una coperta con accanto un cagnetto dall’aria sparuta. Il barbone aveva in mano una radiolina che teneva come si tiene un oggetto prezioso e dalla quale usciva il suono di una canzone.
Lei si fermò a guardarlo. Lui le sorrise:
– Bella canzone, vero? E che stupenda giornata! Fai una passeggiata?
Si, una passeggiata.
E non ce l’hai l’innamorato? Sul fiume bisogna passeggiare con l’innamorato.
No, non ce l’ho.
Coraggio, vedrai che lo troverai presto. Sei così carina! Anche se forse non sei più molto giovane. E’ vero?
Si, è vero. Non sono più molto giovane.
Lei gli sorrise e si allontanò. Pensare che un uomo come quello, un barbone, un reietto della società, aveva cercato di consolarla, di darle una speranza. Da dove attingeva tanta forza e tanta serenità? Avrebbe voluto chiederglielo per trovarne un po’ anche lei.
Intanto il cielo si era completamente scurito e sul ponte brillavano le luci dei lampioni, mentre un suono di risate giungeva di tanto in tanto , laggiù , in quell’angolo appartato sulle rive del fiume.
Continuò a camminare sulla banchina finchè fu lontana dal barbone. Adesso il punto in cui si trovava era il più solitario e silenzioso.
Aveva preso la sua decisione: per dare un senso alla sua vita e per essere coerente con i suoi sogni, la sua morte sarebbe stata come quella di un personaggio tragico, come Ofelia, annegata nelle acque del fiume.
Recitò il brano in cui Gertrude racconta la morte di Ofelia:
C’è un salice che cresce di traverso a un ruscello e specchia le sue foglie nella vitrea corrente; qui ella venne, il capo adorno di strane ghirlande di ranuncoli, ortiche, margherite e di quei lunghi fiori color porpora che i licenziosi poeti bucolici designano con più corrivo nome
ma che le nostre ritrose fanciulle chiaman “dita di morto”; ella lassù, mentre si arrampicava per appendere l’erboree sue ghirlande ai rami penduli, un ramo, invidioso, s’è spezzato e gli erbosi trofei ed ella stessasono caduti nel piangente fiume. Le sue vesti, gonfiandosi sull’acqua,
l’han sostenuta per un poco a galla, nel mentre ch’ella, come una sirena, cantava spunti d’antiche canzoni, come incosciente della sua sciagura o come una creatura d’altro regno e familiare con quell’elemento. Ma non per molto, perché le sue vesti appesantite dall’acqua assorbita, trascinaron la misera dal letto del suo canto a una fangosa morte. »
“Mi mancano le ghirlande di ranuncoli, ortiche e margherite- pensò ironicamente- ma anch’io galleggerò sulle acque del fiume a conclusione di un destino tragico”.
Si lasciò scivolare nell’acqua.
Due giorni dopo fu ritrovato il suo cadavere, gonfio e irriconoscibile.
Il Sessantotto di Penelope
di Fatima Guido
La superficie usurata, segnata da graffi, l’azzurro sbiadito, la molla del manico bloccata, ma lui, quel piccolo mangiadischi, faceva sempre il suo dovere: addentava i 45 giri del momento e restituiva senza inciampi i suoni delle canzoni dei loro idoli.
Le note trite e ritrite, ascoltate fino allo sfinimento, accompagnavano le chiacchiere, riempivano quei lunghi e rari pomeriggi di confidenze con Maria, la bella cugina, quindicenne amata e ammirata; musa ispiratrice delle sue quotidiane coreografie solitarie, esibite su quel gelido terrazzino della casa di Nicefori, un piccolo paesino ai piedi dell’Etna, in cui Paola si era sentita relegata da due anni. Gli anni della sua tarda infanzia.
Occhi verdi, capelli lisci, gambe lunghe, intelligenza, coraggio. A Maria non mancava proprio nulla; nulla si intende che non fosse in grado di smuovere l’invidia delle altre donne.
- Vieni, voglio mostrarti una cosa – le sussurrò Maria con fare ammiccante quel sabato pomeriggio di ottobre.
- Cosa?
- Questo. L’ho preso ieri alla Standa – e tirò fuori dalla sua borsa un vestito color malva.
- Penso di metterlo sabato sera, quando andrò a ballare con Lucio – disse Maria, sorridendo. Lo sguardo acceso da una luce viva, trasgressiva.
- Sei pazza? – rispose Paola con aria preoccupata. E’ troppo corto! Tua madre non te lo farà mai indossare! Anzi, se lo vede tuo padre, capace che non ti farà più uscire!
- Ma io lo nasconderò nella mia borsa e lo tirerò fuori solo dopo che sarò in discoteca: mi chiuderò in bagno e mi cambierò.
- La stanza risuonava sempre della voce del cantante preferito del momento e per il quale Maria – ne era certa – avrebbe fatto follie.
“Occhi neri non mi vuoi più nel tuo cuore. Occhi neri vai con lui, ma non è amore”.
- Sai? – disse Maria – ieri ho conosciuto un ragazzo che somiglia a Mal, Valerio, ci siamo baciati, siamo innamorati persi e sono sicura che sarà per sempre –
Paola era ancora una bambina, ma non le dispiaceva ascoltare quelle canzoni d’amore. Amava però anche quelle cosiddette di protesta, perché tratteggiavano un mondo che per Paola era ideale e nutrivano in lei la speranza di un suo avvento. Paola mandava giù con entusiasmo a memoria tutte quelle parole ricche di promesse piegate alla musica, ma, a volte, le succedeva di non comprenderne alcune. Le giungevano come deformate. Allora, quando canticchiava e tentava di ripeterle, si fermava a riflettere sul loro significato; si rendeva conto che così come le erano arrivate non avevano senso e quindi selezionava dal suo vocabolario personale, altre parole dal significato – a suo dire – più calzante e dal suono simile.
– Sì, deve essere per forza questa la parola che non capisco – diceva tra sé e sé.
Se ne convinceva a tal punto che prendeva a ripetere la canzone e a reinterpretarla, cambiando, se necessario, anche altre parole per restituirle un senso che sembrava sfuggirle.
Tutte le volte che canticchiava dei brani monchi di senso però, giunta al punto in cui la sua razionalità era intervenuta a risignificarli, per un microsecondo la sua mente si annebbiava. Doveva fermarsi a pensare, ricordare, interrompendo il flusso di quelle melodie. A volte, passavano persino diversi anni prima che riuscisse a decifrare le parole incomprese e a restituire al testo il significato originario.
– Ah, era questo che non avevo capito? Era così semplice? Banale?
- Banale? Forse. Eppure così apprezzato – pensava.
- Può darsi che, a questo punto – si diceva – sia io quella che non sa valutare, apprezzare; forse non so emozionarmi.
- E se fosse sufficiente credere di provarle le emozioni per sentirle sul serio? Appiccicarsele addosso, scipparle dai volti, dai gesti degli altri e riprodurle poi sul proprio volto? Le stesse espressioni, gli stessi gesti. In fondo è facile!
E col tempo, Paola si impratichì in quell’arte e divenne esperta anche nella ricerca di senso.
Ma a volte capitava ancora, quando ascoltava un brano nuovo, che qualche parola le sfuggisse; e anche a distanza di tempo, nel risentirlo, quella parola continuava a rimanerle oscura. In quei casi accadeva puntualmente, che una parte di lei si levasse in piedi per ribadire a bassa voce a quell’altra che canticchiava: “qui c’è qualcosa che non quadra. Questo suono non ha senso. Ricomincia daccapo”. E non c’era verso di metterla a tacere. Paola ci aveva provato più volte; aveva provato ad ignorarla, orientando il flusso dei suoi pensieri in altre direzioni, verso altre canzoni. Ma quel testimone perennemente presente, ascoltava tutto e, quando Paola meno se lo aspettava, ecco che si intrometteva per correggere, per costringerla a rivedere le parole della canzone che aveva in mente.
E la ricerca di senso riprendeva. La ossessionava fino a che essa non fosse riuscita ad afferrarlo o perlomeno voleva credere di averlo afferrato.
Certo che a volte le parole sono strane, entrano nella vita dei bimbi; la mamma, i fratelli, gli zii, gli amici, le maestre, tutti le usano e tutti trascinano i bimbi nel loro mondo; mondo di suoni misteriosi, di suoni che penetrano nella mente, che fanno da cornice gradevole (ma insensata) alla comunicazione.
Uno fa il bravo, accoglie quei suoni, li elabora, dà loro quel senso che – si sa – devono avere, è persino felice di vorticare in quel mondo. Suoni, parole, sensi che tutti condividono e che li fanno stare insieme, poi…
Poi un bel giorno scopre di non capire; o meglio, il senso di alcune di quelle parole che si credeva di avere svelato, membri ormai legittimi della famiglia della propria lingua, ecco che quel senso si maschera. Se ne coglie ancora il suono, certo, ma suono e significato, che prima coincidevano, ora contrastano: il suono va in una direzione, il significato in un’altra e alla fine non ci si capisce più nulla.
Nonostante questo, però, si va avanti lo stesso.
E questo fece Paola: andò avanti.
Erano gli anni Settanta, gli anni del liceo. Tanti gli amici persi dietro ad un pugno alzato, dietro a un “ora è giunto il tempo della Rivoluzione”. Ma quella spinta – anche se allora non si sapeva – si nutriva di musica; dietro c’era solo la musica; c’erano ancora una volta canzoni stracolme di parole che i suoi amici intonavano fuori scuola, nei cortei e nelle piazze; tante parole che loro conoscevano a memoria e che per loro sì che avevano senso.
- Perché non vieni con noi oggi? Facciamo calia e andiamo a manifestare – le disse Beppe. La voce rauca, i capelli corvini, lunghi e spettinati. La battuta sempre pronta a dissacrare, l’aria ribelle e scanzonata.
- Dove? Perché? – chiese Paola.
- Perché vogliamo cambiare le regole. Partiamo alle 9.00; corteo fino a piazza Duomo e poi andiamo a prendere un gelato, a fumare un po’ e a cazzeggiare. Dài, vieni che ci divertiamo!
Beppe non perdeva occasione per fare proselitismo, perché – a suo dire – il numero avrebbe fatto la forza. Era caruccio, ma non la attraeva fisicamente, non era il suo tipo; era solo un caro amico, anche tanto divertente, ma non riusciva a coinvolgerla, né sentimentalmente, né politicamente; anzi, come per tutte le altre emozioni, anche quella politica era per Paola solo un’emozione presa in prestito e le sue manifestazioni, solo una riproduzione – nemmeno tanto fedele – di quelle degli altri. Quei brani poi che Beppe ascoltava contenevano troppe parole e alcune di esse le erano oscure più di altre, di tutte quelle altre che Paola aveva depositato nell’archivio mentale dei termini dal senso astruso e che erano ancora in attesa di essere decriptati.
- Forse la vita si costruisce a parole – si diceva Paola. I libri, la TV, la radio, le poesie, le canzoni, le discussioni, le lezioni, tutto sembra fatto di parole, alcune dal senso noto oggi, ma sempre in bilico, in pericolo di smarrirsi; altre totalmente ignote nel suono e nel senso –
E più pensava così, più si sentiva confusa, disorientata. Come un pesce fuori dall’acqua, Paola si sentiva fuori dalla vita.
I suoi amici credevano di starci dentro invece; non pensavano tanto all’amore, quanto alla rivoluzione che avrebbe rovesciato il sistema, lottavano riempendosi le bocche delle note di “Dio è morto”.
- Come si fa una rivoluzione di successo? – Cominciò a chiedersi Paola –
Fino a qualche anno prima se ne parlava tanto, la si cantava, ci si credeva. Vestiva di luce le speranze della generazione di allora ed anche le sue. La rincuorava l’idea dell’approssimarsi di quel futuro urlato a suon di musica ribelle, raccolto nei capelli e nei fiori di quei giovani.
- Ma quella rivoluzione – si domandò – era la stessa cercata e cantata oggi dai suoi amici? –
Chissà! Di certo, allora come ora, era gonfia di parole, di suoni che pretendevano di dare un senso al pensiero.
Forse allora il difetto stava tutto lì: gli spazi di tutti – già tanto angusti – sono affollati di suoni, segni e senso comune. Forse occorre liberarli. Ma come?
A queste domande Paola non seppe trovare una risposta, ma se lo sentiva: il nodo doveva stare nella moltitudine delle parole in cui tutti noi ogni giorno anneghiamo e nel loro assoggettamento ad un senso comune.
- Quanto sei complicata! – esclamò Giulia che ogni tanto raccoglieva quelle strane confidenze e intanto dalle casse del suo giradischi uscivano suoni di parole di protesta di un brano già vecchio di qualche anno: “di disgrazie puoi averne tante, per esempio una figlia artista… O peggio ancora uno comunista”.
Giulia era l’amica “alternativa”, brava a scuola, ma non particolarmente studiosa; sempre aggiornata comunque sugli avvenimenti politici del tempo, raccontati – a suo dire – con “estrema precisione, veridicità e trasparenza” dal quotidiano con cui si accompagnava a scuola.
- Se non ti esprimessi a voce, per iscritto, o anche solo a gesti, non potresti farti capire – proseguì Giulia – Tu non capiresti niente e, nessuno, cara Paola, nessuno capirebbe te.
- E’ proprio necessario capire o farsi capire? – domandò Paola – Vedi io mi chiedo ora, per esempio, cosa dice questo Lolli a questo punto del brano:” sempre ? a scrutare un orizzonte che si ferma al letto”
- “Sempre fissa lì a scrutare” – precisò Giulia – e poi dice al “tetto”, non al “letto” –
- Ecco – disse Paola – non mi era chiaro, stavo per modificare tutta la frase, tanto non ne avrei intaccato il senso. O no? – e sorrise con un pizzico di ironia.
I gelidi occhi azzurri di Giulia la fissarono con disappunto: non aveva gradito la sfumatura ironica dell’amica. Lei ci credeva nelle parole, era certa di possederne il senso e sapeva riproporle agli altri in maniera convincente. Non le capitava di perderle, di perdere il loro senso.
- Ieri siamo andanti al ritrovo – continuò, cercando di cambiare discorso- Salvo è arrivato dopo le 17 e ha chiesto di te. Ho detto che eri rimasta a casa a studiare. Secondo me gli piaci e penso di non sbagliare quando dico che anche a te piace lui – E sorrise ammiccando con gli occhi.
- Sì? Cosa te lo fa credere? Rispose Paola.
- Hum, forse il modo in cui lo guardi, in cui ridi quando lui fa qualche battuta spiritosa. Non so, sento di avere ragione. Sbaglio?
Sbagliava? Paola non sapeva dirlo. In effetti, c’era qualcosa di Salvo che la attirava, ma non aveva dimestichezza con le sensazioni d’amore; conosceva quelle delle altre, quelle di Maria, ad esempio; sapeva come si fa a manifestarle, aveva imparato scimmiottare le altre, a far credere a tutti che anche a lei accadeva di viverle, ma non era ancora sicura di provarle veramente.
Salvo non era bello, ma aveva un certo fascino. Gli occhi scuri, profondi, le mani curate, calde, che tante volte avevano sfiorato le sue. Avevano anche ballato un lento una volta a casa di Marco, abbracciati stretti stretti. Lui non pensava alla rivoluzione, anzi osteggiava le convinzioni degli altri, perché, a suo dire, tutte le rivoluzioni sono destinate a fallire. La storia glielo aveva insegnato.
Il padre di Salvo gestiva una piccola impresa. Si era portato avanti con fatica; aveva iniziato a lavorare sin da piccolo presso l’officina meccanica del quartiere. Tante ore di lavoro sottopagato; tanti sacrifici, ma alla fine ci era riuscito: con i soldi messi da parte, aveva rilevato un piccolo locale e lo aveva trasformato in un’officina. Oggi gestiva quattro impiegati e aveva svelato al figlio tutti i trucchi del mestiere. Un giorno Salvo avrebbe ereditato l’attività del padre.
- Perché sabato non sei andata a manifestare con gli altri? – Le chiese Salvo.
- E tu? Perché sei entrato a scuola assieme a quei quattro stronzi che non perdono occasione per farsi belli agli occhi dei professori? – Rispose Paola.
- Perché io non credo a quelle minchiate: le manifestazioni in piazza, le rivolte studentesche, il comunismo di comodo. Tutte scuse per non studiare! Questo però non vuol dire che io sia fascista, né stronzo e penso sinceramente che anche tu non lo sia; anche tu, come me hai scelto di entrare. Quindi? –
- Non so ancora cosa sono – confessò Paola – So solo che, a volte, perdo il senso di alcune parole; se poi le parole sono tante, non sono sicura di riuscire a ricordarle tutte e quelle dei nostri compagni, comunisti, fascisti, o democratici, o quello che cazzo vuoi tu sono troppe da ricordare.
Glielo aveva detto. Aveva avuto il coraggio o l’incoscienza di rivelare a Salvo il problema che la tormentava. Chissà cosa avrebbe pensato ora di lei?
- Ma che cazzo dici? – Salvo sorrise, ma era chiaro che non aveva capito. Forse non era importante capirla. Almeno non era importante capirla fino in fondo. Era sufficiente intendersi sul piano fisico, o almeno provarci. Salvo la desiderava, ma non sapeva dimostrarglielo – almeno non in modo da convincerla a baciarlo.
Accadde una sera di giugno, fuori dal bar dove erano soliti ritrovarsi la domenica. Salvo aveva trovato la maniera per rimanere solo con lei e a lei questo non era dispiaciuto.
- Hai visto l’ultimo film di Lucas?
- Sì, certo. Bello. Secondo te, esistono gli extraterrestri? Sono già tra di noi? – chiese Paola –
Salvo si fermò un attimo a riflettere: cercava la risposta giusta, quella che potesse compiacerla, ma che nel contempo non accendesse inutili discussioni. Non poteva aprire un dibattito, un lungo scambio di vedute sui mondi e le diversità tra gli umani e i potenziali esseri che abitano galassie vicine o lontane. Né poteva avventurarsi in un terreno di scontri politici, lui che aveva chiaro quanto fosse stupido schierarsi. Proprio lui che giudicava inutile ogni tentativo di lotta, di cambiamento, che amava ripetere come una sorta di litania il proverbio caro agli antichi munnu è statu e munnu è. No. Salvo aveva solo fretta di concludere, voleva baciarla, toccarla. Così fermò con un bacio tutti gli altri interrogativi che stavano per uscire dalla bocca di Paola.
La loro storia, povera di emozioni, ma gremita di parole andò avanti per un po’, fino al giorno in cui Salvo, stremato da quelle che definiva “le pippe mentali” di Paola, abbandonò la speranza di riuscire a capirla e cambiarla e prese ad uscire con un’altra.
Paola non seppe mai se ne rimase ferita o liberata. Non seppe mai dare un nome a quello che provò in quei giorni. Le sembrò che somigliasse vagamente a ciò di cui aveva tante volte dissertato con Maria, ma non era sicura di riuscire a definirlo in maniera esatta. E quella volta Paola rinunciò a ricercarne il nome.
Venne un nuovo autunno e ricominciò la scuola. Tutti si ritrovarono un po’ cambiati nei volti, nei capelli, nelle mode, ma il pensiero della rivoluzione non aveva lasciato quei suoi compagni, che – anzi – avevano ora nuovi motivi (musicali e reali) per renderlo più ardente e chiassoso. Era l’anno degli indiani metropolitani, delle radio libere e del piombo dei brigatisti, scaricato con generosa abbondanza sul “sistema”.
Beppe non mollava: era chiaro che avrebbe voluto iniziare Paola alle nuove lotte, e così la invitò a seguirlo a casa di Ennio.
Le camicie di jeans con maniche sempre un po’ fuori misura per la lunghezza delle sue braccia, piccolo di statura, gli occhi grigi, i capelli rossicci e la bocca sempre umida, tanto che quando parlava emetteva suoni, saliva, e poche parole, semplici e ripetitive: questo era Ennio. Era un militante di lotta continua. Una volta aveva partecipato all’occupazione di una fabbrica, perché il padre di un suo compagno era stato licenziato ingiustamente e, a suo dire inoltre, tutti gli operai e gli impiegati di quell’impresa venivano sistematicamente sfruttati e malpagati; tanti tra loro non avevano neppure un regolare contratto. Peccato però che anche il proprietario di quella fabbrica fosse uno di poche parole: poche parole e tanti fatti, preceduti da intimidazioni, neanche tanto velate, che persino dai giovani più attivi (giovani senza macchia né paura) venivano subito associate al ricordo di qualche “regolamento di conti tra bande rivali” (raccontavano i giornali nazionali) o “di un’esecuzione mafiosa”, (per la gente del posto) e questo ricordo era bastevole a indurli a desistere dalla lotta, o meglio, a indirizzare altrove la loro lotta.
Quel giorno Paola decise di seguire Beppe. La stanzetta tappezzata a tratti da cartoni di uova per “ripulire” – si credeva allora – i suoni degli strumenti, della batteria di Ennio, così da non beccarsi denunce per disturbo della quiete pubblica; il resto delle pareti era rivestito da carta da parati unta e sbiadita, qua e là sbrindellata, ricca di grandi rose dal colore ormai indefinibile; alcune penzolanti che sembravano essere state recise da mano inesperta. La foto del Che campeggiava sul muro contro il quale poggiava la piccola libreria affollata di cassette musicali, dischi e libri. Ennio aveva trasformato la sua stanza in una stazione di radioamatore, dalla quale trasmetteva improbabili notiziari e tanta musica impegnata.
Il pomeriggio trascorse tra vino, chiacchiere, musica, fumo e noia.
Paola non riusciva a respirare né quel fumo, né quel clima e agli occhi di Ennio dovette apparire come una piccola, stupida borghese, dal momento che mostrava di non partecipare con entusiasmo alla conversazione e al fumo; neppure le canzoni intonate a mo’ di inno da Beppe ed Ennio riuscirono a coinvolgere Paola, che le ascoltava senza partecipare, ma con grande attenzione perché voleva capirne fino in fondo il significato. Quando però confuse “dalle fabbriche in rivolta” con “le fabbriche ad una svolta”, Ennio sbottò:
- Senti un po’ Beppe, ma chi hai portato? Una borghese di merda? Ci sta prendendo per il culo?
- Ma no ‘mbare! – rispose Beppe, con un pizzico di malcelato fastidio – è una compagna solo un po’ imbranata.
Il giorno dopo Paola ed Ennio si incrociarono dentro scuola, ma Ennio non la salutò; anzi, da allora in poi non le rivolse più la parola. Paola non se la prese più di tanto: era abituata ad essere fraintesa, l’equivoco sembrava essere divenuto ormai la cifra distintiva del suo destino.
Intanto in classe sua era arrivato un nuovo compagno: Luca, magro, capelli neri, baffi e pizzetto, fascista per diritto ereditario (il padre e i fratelli militavano nel MSI e anche il nonno aveva indossato a suo tempo con orgoglio la camicia nera), cosa questa che il ragazzo proclamava con spocchia in tante occasioni (soprattutto quando stava con i suoi camerati) e che però gli era valsa una volta una costola rotta e ora era motivo di isolamento dagli altri compagni. Tuttavia, a Luca di questo non fregava nulla e anzi sembrava divertirsi a provocare spesso gli altri anche a suon di musica.
“Compagno sì, compagno no, compagno un cazz”, intonò un giorno in cortile e quel giorno la ricreazione finì in una rissa, sedata a stento dall’unico bidello presente nei paraggi. I responsabili vennero subito convocati in presidenza per una breve ramanzina e segnalati con nota disciplinare, ma subito dopo le lezioni ripresero comunque.
Al rientro in classe li attendeva lei, la loro insegnante di lettere, trasferitasi a inizio anno in quella scuola, anch’essa impegnata in politica, ma nei cui occhi brillava una luce nuova, diversa da quella che Paola era solita cogliere negli altri “compagni”, coetanei o adulti che fossero. Una luce che colpiva Paola come una sorta di laser e che sembrava sospendere il tempo delle lezioni. Luisa aveva fatto il ’68 (come spesso amava ripetere) e aveva scelto di seguire una didattica alternativa: letture di quotidiani di sinistra cui seguivano lunghi dibattiti che riempivano ore di lezione.
Quella donna aveva una personalità magnetica. Gli occhi verdi, un po’ appesantiti da un tratto marcato di eye-liner nero che indossava tutti i giorni. Lunghi capelli corvini, sempre sciolti, le incorniciavano il viso. Bello, ancora giovane.
Bella sì. Era bella Luisa, un po’ distaccata forse, almeno così appariva, per via di quel portamento rigido, quasi fiero che incuteva rispetto e una certa soggezione, ma a Paola portava via le parole.
Luisa non aveva avuto figli – Chissà perché? – Si era chiesta più volte Paola, ma non aveva mai osato domandarglielo. Si era accontentata di ricostruirne le ragioni spiandone di nascosto certe espressioni, certi sguardi che ogni tanto le rivolgeva, alcune sue vaghe affermazioni e quei piccoli, quasi impercettibili, movimenti delle mani e del capo che Luisa era solita fare quando si compiaceva dei suoi discorsi e del feed-back positivo che riceveva dai suoi studenti. Allora, solo in quei precisi momenti, Paola avvertiva come una strana sensazione, come un sottile diffondersi di qualcosa che le scaldava il cuore e che prese poi a guidare l’ostinata ricerca di tante risposte. Forse c’era stato un tempo in cui li aveva anche cercati i figli – si disse Paola – Una piccola finestra temporale che era stata spalancata in modo repentino ed inaspettato dal vento della maturità, che aveva spazzato via tutte le retoriche del ’68 di Luisa e che le aveva portato il richiamo della maternità. Ma quel desiderio, per qualche ragione, era rimasto poi irrealizzato e così lei aveva deciso di riempire quel vuoto di libri, impegno politico e artistico.
Il suo compagno. Quello sì che a Paola era parso essere il figlio. Lo aveva conosciuto in occasione delle prove di uno spettacolo di cui era regista.
– Sposta quel tavolino! La protagonista deve occupare il centro della scena – le aveva detto con fare perentorio Stefano. Luisa si era alzata di scatto dalla poltrona che occupava (la numero sette, della prima fila, in quel piccolo teatro che la loro compagnia aveva preso da poco in affitto). E con quale premura (Paola lo aveva notato) Luisa supportava Stefano nel dirigere le sortite degli attori, le pause.
Contrariamente a quanto si temeva, l’episodio della rissa sembrava non aver sortito ulteriori conseguenze; Luisa, come tutti gli altri docenti, ne era stata informata, ma non parve arrabbiarsi particolarmente, tanto che quel giorno evitò di approfondire l’accaduto.
- Oggi facciamo lezione in modo diverso – esordì Luisa: ho con me un disco che voglio farvi ascoltare –
- Ancora musica! – Pensò Paola che si aspettava qualcosa pieno zeppo di parole che, come spesso le succedeva, temeva di equivocare; anzi, lì per lì, sentì che questa sua difficoltà potesse essere amplificata dal sorgere in lei di quella strana sensazione che si presentava tutte le volte in cui Luisa spiegava, quando cioè tornava ad essere la donna distante e fiera di sempre. Era come una sorta di soggezione, un timore reverenziale che inibiva Paola e la rendeva docile.
E le parole arrivarono, parole che pretendevano di insegnare cosa fosse la libertà.
- La libertà non è star sopra un albero, ma è partecipare. Io so, ragazzi, cosa vuol dire partecipare al cambiamento, perché io ho fatto il ’68 –
- E cosa volevate cambiare professoressa? – chiese Beppe con un sorrisetto ironico –
- Volevamo cambiare il mondo – rispose sicura Luisa – Credevamo nella possibilità per noi giovani di allora di riuscire a realizzare un mondo pacifico, solidale ed equo.
- Equo? – intervenne Luca, la voce carica di rabbia e risentimento – Non capisco perché voi comunisti ci teniate tanto ad appiattirci tutti, a voler annullare ad ogni costo le differenze naturali e giuste tra gli uomini. Il mondo è come una piramide: in cima ci stanno quelli più sani, capaci e – perché no? – anche più ricchi. In basso…
- Chi starebbe in alto a quella scala? Tu? – Lo interruppe Giulia, con una smorfia di disgusto – Ma ti sei visto?
Il dibattito era divenuto acceso, ma Paola ascoltava con scarso interesse; non riusciva a staccare lo sguardo da Luisa. Se la figurava nel suo tempo, ricco di colori e suoni e parole. Immaginava il suo mondo, quel mondo equo, libero, solidale e in pace. Conosceva il suo sogno e in qualche modo, Paola ci era finita dentro. Che fine aveva fatto la loro rivolta? C’era ancora qualcuno che stava continuando a lottare, magari in gran segreto?
- Scusi professoressa, avrei una domanda?
- Dimmi Paola – rispose distesa Luisa –
- La vostra rivoluzione…Sì, quella del ’68…Era la stessa di quella dei ragazzi di oggi o era altro?
- Era solo l’inizio. L’inizio di un cambiamento di enorme portata. Certo, il movimento di noi giovani di allora ha subito come una battuta d’arresto; ma ora, grazie a voi, alla vostra lotta, sta riprendendo vita. Tocca a voi oggi, cari ragazzi, continuare l’opera che è stata interrotta, abbattere le roccaforti imperialiste che si ostinano a mantenere un ordine mondiale basato sullo sfruttamento dei popoli del Terzo mondo e sulle disuguaglianze sociali.
- Roccaforti imperialiste? – ripeté tra sé e sé Paola – Oh Dio! Ecco che ci risiamo! –
– Queste due parole le risuonarono strane: sapeva cosa fossero (la sua prof ne aveva già parlato in classe), ma stavolta, stranamente, provò anche a localizzarle con più precisione. Le roccaforti le apparvero disseminate un po’ ovunque nel mondo; nel Primo, nel Secondo; magari erano anche vicinissime a loro. O forse no? No. A Paola apparivano lontane; tanto lontane da loro, da sé. Forse erano addirittura altro da loro, altro da sé.
- Hai sentito oggi la prof? – chiese Giulia incollerita – Cosa saremmo noi? Un’appendice della loro rivoluzione? Gli eredi del loro fallimento? No. Noi facciamo sul serio! Combattiamo per noi che non abbiamo un futuro. Non abbiamo il culo al caldo noi. Ecco come si fa una rivoluzione! – continuò Giulia con un sorriso beffardo – e alzò in alto la mano destra; il pollice aperto, l’indice e il medio, uniti e tesi a simulare la forma di una pistola.
L’urgenza di quelle esternazioni di intento violento gettarono Paola nello sconforto; i volti di Giulia e degli altri come lei le sembravano solo maschere deformi. Miseri calchi di volti allegri all’apparenza, dietro cui si celavano invece disperazione e angoscia. L’angoscia di una generazione allo sbando.
E cosa ne era stato del suo sogno? E del sogno di Luisa? Quel mondo mitico, vagheggiato e atteso, era ormai agonizzante. Sepolto da una coltre di macerie di parole.
Quello di Giulia era solo un mondo spezzettato in tanti insiemi di giovani vite, ciascuno isolato dall’altro, chiuso in un “qui ed ora” scandito da suoni stridenti.
– Ehi, mi stai ascoltando? – chiese Giulia –
– Ehi, dico a te, Paola.
Ma lei sembrava che quasi non l’ascoltasse. Sembrava non capire o non sapere cosa dire. Forse non trovava le parole. Forse ancora una volta aveva perso il senso.
Il Sessantotto di Ulisse
di Rocambole Garufi
A lui quelle vacanze sembravano un niente.
Al più, lo portavano a un triste pensare.
C’era troppa ciccia unta e tremolante, oscenamente in luce.
Sotto gli ombrelloni, la sabbia era marrone, opaca e solcata da ignobili rughe. Lungo la riva si sentivano gli elicotteri, a coprire la voce del mare. Aveva quasi il sospetto di trovarsi in un lager ben organizzato. Lì, la morte era come il trucco: c’era, ma non si vedeva.
Le anime dei bagnanti non salivano verso il cielo – come il fumo delle vittime dell’Olocausto – e non correvano dentro il vento! S’impigliavano nei riccioli sporchi di corpi abbronzati e senza mistero, diventavano un misero guizzo in un mare liscio come l’olio, mentre la madama con la falce mieteva il suo grano.
Tutti guardavano culi e tette in esposizioni da grandi magazzini. Topless e bikini, perciò, servivano soltanto a coprire ciò che era ipocrita velare e a scoprire ciò che era conveniente disvelare.
Egli spesso pensava che la Moira – vabbe’… la morte! – fosse l’unica dea trionfante. La morte poteva persino permettersi il lusso di star serena, mentre attendeva.
L’eternità è sicura, soltanto quando parliamo della morte.
Da ragazzo, figuratevi, lo incantava la lettura del Foscolo.
Nella noia del collegio, una sera gli capitò di scrivere, in margine ai noti versi di Quasimodo:
Or, ch’è subito sera,
C’è la morte e non c’è nessun mistero.
Mi aspettava, sicura del mio sì,
Sapendo la mia strada e sorridendo.
Aveva sedici anni.
Quel serpente gli restava nelle viscere. Si contorceva ed iniettava veleno. Gli sarebbe parsa impazienza, se avesse saputo cosa voleva. Forse erano gli intellettuali ed astratti furori del Vittorini di Conversazione in Sicilia.
Provò a distrarsi, pensando alle montagne valdostane di quando era a Ivrea.
Anzi, no! Meglio i picchi del Trentino, dove fu prima.
In Trentino la neve può diventare dura e luminosa come il vetro. In un lontano giorno aveva visto barbagli di perla sulle pareti verticali che si elevavano incombenti.
Dal trenino che lo portava a Malè, nel cuore della Val di Sole, poteva intravedere il cielo soltanto di scorcio. Stava lassù, molto in alto, oltre le cime. Il suo colore aveva riflessi d’argento.
Accese l’ennesima sigaretta, sapendo già che il solo effetto sarebbe stato un aumento del mal di testa.
Davanti a lui un bagnante andava scuotendo un piccolo canotto, di quelli della Standa. Duri granelli di sabbia gli arrivarono alle narici e agli occhi. Lo guardò bieco, ma questi non mostrò neppure di accorgersene.
Allora, si disse che, le sue, erano reazioni e riflessioni banali; di quelle, appunto, che si potevano avere nell’ozio di una spiaggia. Ma, provateci voi, gentilmente, a trovare l’originalità nel succedersi millenario delle vite e delle morti!
Guardò la moglie che guazzava a riva.
La vide meno bella del solito. I fianchi erano larghi, molli. I neri e lunghi capelli, anche se riflettevano stille di luce, le si erano appiccicati in testa e gliela rendevano sproporzionatamente piccola. Un grande uccello dai movimenti goffi.
La sua forza animale si addensava nel peso del seno e del sedere. Soltanto le gambe avevano la liscia bellezza del fusto di una colonna corinzia.
“Vieni in acqua!” gli gridò lei, vedendosi osservata.
“No” rispose.
Chiuse gli occhi con la faccia al sole e rivide il viso di sua madre.
Aveva quattro/cinque anni, stava col gonnellino lungo e sporco delle gustose pappine della nonna – pane bollito nel sugo dell’estratto di pomodoro -, dal comodino saltava sul gran letto matrimoniale.Sua madre vi campeggiava enorme e lo racchiudeva tutto.
Poi, gli venne in mente un’altra età, anch’essa lontana.
Seduto sui gradini di una casa, scrutava sotto le vesti di una bambina. Stava senza un briciolo di coraggio e senza dire granché, mentre intravedeva come un solco su una pagnottella. Eppure, poco dopo illustrava a una compagnia di adulti burloni la cosa che hanno le donne, facendone persino un disegnino barocco…
Ah, se tanta fantasia fosse durata!
Invece, a sedici anni se la passò bene, tutto sommato.
C’erano le feste mattutine con le quali dalle sue parti si celebrò il Sessantotto. Cinque giorni su dieci, si marinava in massa la scuola e si andava a ballare.
Allora Franca era larga e matronale. Portava i capelli corti, a caschetto. Sembravano fili di seta nera. Ed anche gli occhi erano neri, secondo i canoni di una immaginazione araba, col taglio stretto ed obliquo. Aveva immolato la sua verginità in una precedente, tempestosa relazione – con chi? Non riusciva a ricordarne il nome -.
Prima, fra loro ci fu platonica amicizia e poi libero amore.
Libero pure di bere. Datava da quei tempi la sua nausea per il martini, per via di una solenne sbronza. Quando si lasciò cadere come un sacco sul letto, la stanza ronzava forte e irregolare. Prese un volo faticoso, la stanza, e le pareti vibravano. Vomitare fu un grande, ma momentaneo, sollievo.
Due anni prima l’aveva rivista, la dolce Franca. A Torino, stampata sul cartellone di un cinema a luci rosse. Il suo nome campeggiava a lettere cubitali. Volgare come gli anelli dei malavitosi.
Un’accusa, gli era parsa.
Anche la signora coi capelli ricci, il seno rotondo ed il cantilenante accento catanese aveva una risata volgare. Al ricordo ne provò quasi eccitazione. Rideva e gli tastava il pene di undicenne, che non riusciva a diventare duro.
“Torna in bagno, vah!” gli disse. “E concentrati di più. Non ci fai niente a una donna, con un cosino tanto piccolo!”
La vita ha molte sconfitte, ma sono le prime quelle che ti restano impresse.
Poi, ecco la ragazza di Scordia, con i capelli rossi e le labbra tanto prominenti che ne scorgeva la punta, da dietro, ad un quarto di profilo. Il suo orecchio, infuocato da un boccolo d’oro, era diafano vicino alla guancia. Aveva tredici anni.
Stavano in piedi su un autobus stracarico. Sentiva le vampate del suo corpo, mentre lo sguardo restava inchiavardato alle linee confuse del paesaggio che scorreva nel finestrino…
Vaneggiamenti, preistoria…
Da cui si riscosse per lo scoppiare del pianto di un bambino.
Una signora con una mongolfiera nella pancia, i capelli ossigenati e due pendenti che a tratti si adagiavano sulle spalle grasse prese il pupo e se lo tirò accanto.
Sua moglie era uscita dall’acqua e si era stesa davanti a lui. Stava immobile.
“Eh, mia cara, se sapesse!” ciàcolava la bionda Giunone. Non si era accorto che tra quelle due era scoppiata l’amicizia. “Sono vedova da tre anni e non sto qui a dirle i sacrifici dei primi tempi… E quanto mangia, questa mia creatura!”
Sua moglie ebbe un impercettibile movimento. Annuiva così.
“Lo saprete presto, quanto mangiano i figli!” continuò la Giunone, guardandolo – egli sorrise per dichiararsi d’accordo -. “Siete sposati da molto?”
“Dieci mesi” disse sua moglie.
“State bene insieme!”
Egli sorrise di nuovo. Le donne ricominciano a tantaferare e a confidarsi, per cui ebbe davanti il quadro che gli aveva predetto l’amica del Piemonte.
L’amica era al volante, ubriaca. Le stava accanto, con gli occhi persi nell’indistinto grigio dell’asfalto e della nebbia, tra Racconigi e Carmagnola.
“Non è la donna per te…” ripeté lei, per la dodicesima volta, riferendosi a sua moglie.
La sua voce arrivava flebile, le parole si capivano a fatica. Probabilmente si sforzava di apparire calma, raziocinante. “Per te ci vuol ben altro!”
“Guida piano” disse lui. “O basterà il becchino.”
Allora, l’amica frenò bruscamente. Con la strada insaponata di nevischio la macchina divenne incontrollabile. Si mise di traverso, andò a sbattere contro il paracarri e sconfinò nei campi. Un faro ne restò accecato.
Pochi secondi in tutto, ma lui li visse al rallentatore, pensando che sarebbe morto e stupendosi della sua indifferenza a quel pensiero.
“Tesoro!” la sentii gridare.
Si affrettò a spegnere il quadro-comandi e lo guardò.
“Ti sei fatto male?” chiese, accarezzandogli la nuca. Ecco, ci sono momenti in cui le carezze hanno grandiosi significati. E’ sempre un peccato inflazionarle.
“No” disse lui. “E tu?”
Erano finiti su un terreno coltivato a mais. Oltre i finestrini, la neve scendeva sfarfalleggiando.
Aveva una sua allegria. Si sentiva lo sciacquare di un fiume. Ce ne sono tanti, in Piemonte.
“Baciami” disse l’amica.
Aveva i capelli castani, inanellati dalla permanente. Gli occhi marrone erano dilatati dall’alcol e dalla disperazione.
“Baciami!” ripeté, urlando.
Prese a percorrergli il collo con le labbra. Lentamente.
Poi gli aprì la lampo del giubbotto, gli alzò il maglione, gli sbottonò la camicia e gli prese un capezzolo fra i denti, dolcemente.
Egli non avrebbe voluto farci all’amore. Anzi, quella sera le aveva detto che tornava da sua moglie.
“Perché?” chiese l’amica, senza pudore nel mostrarsi sconfitta.
“Perché?” ripeté.
“La verità è che non è questa la vita, la vera vita” rispose, con le mani vicino alla faccia, scuotendo la testa, quasi balbettando. “Con te è come starne fuori, neppure ai margini… Io voglio sentirmi dentro, invece.”
Avrebbe dovuto aggiungere che aveva bisogno di Dio. Dio è la comunità, Dio è la normalità. Esisti soltanto se gli altri si accorgono che esisti. E gli altri, per la sua condizione di emigrante, avevano concretezza soltanto se ci si riferiva al suo paese. Sua moglie era il paese. Sua moglie era Dio.
In quel momento, però, in risposta ai baci, poté soltanto prenderle la testa con le mani e dirigerla verso la patta dei pantaloni.
La neve era birichina, candida sulla notte nera. Vide lo squarcio di un tuono, ma non seguì alcun rumore. Soltanto dopo si accorse che, al posto della neve, era venuta una quieta pioggia che merlettava i vetri della macchina e addolciva il paesaggio.
Strano cambiamento di scena! Quanto tempo era passato?
E quanto ne era passato da allora?